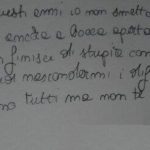La solitudine rappresenta un’imprescindibile condizione umana? Oppure è una scelta? Siamo condannati all’essere soli – come sottolinea Sartre: “l’enfer, c’est les autres” – o possiamo scegliere di sottrarci semplicemente attraverso una comunicazione efficace?
La solitudine rappresenta un’imprescindibile condizione umana? Oppure è una scelta? Siamo condannati all’essere soli – come sottolinea Sartre: “l’enfer, c’est les autres” – o possiamo scegliere di sottrarci semplicemente attraverso una comunicazione efficace?
Troppo spesso ci sentiamo soli, nonostante la spasmodica ricerca di condivisione che caratterizza il ventunesimo secolo: pensieri, azioni e momenti di vita più o meno intimi impazzano sui social al triste scopo di ottenere un riconoscimento, un segnale che esistiamo. Seguendo il ritmo frenetico delle nostre vite comunichiamo costantemente al mondo dove siamo, cosa stiamo per fare, quanto abbiamo lavorato, cosa abbiamo mangiato, il tutto corredato dall’immancabile selfie a testimonianza della nostra sincerità. “Postiamo” di tutto, spesso senza risparmiare neppure i minori, i nostri figli, i cui volti circolano in rete alla mercè pressoché di chiunque. Poi, però, non siamo in grado di riconoscere i nostri condomini e probabilmente nell’ultima settimana non abbiamo mai chiesto il più semplice “Come stai?” neanche a nostra madre. O magari, non siamo capaci di comunicare davvero quello che pensiamo o di capire realmente quello che ci viene detto. Così social, così soli.
La celebre dicitura “L’uomo è un animale sociale” sottolinea la caratteristica di bisogno primario della socialità, ponendola sullo stesso piano delle necessità biologiche funzionali alla sopravvivenza, come la soddisfazione della fame e della sete. C’è qualcosa insito in noi che ci spinge costantemente verso l’Altro, un bisogno che lo psicologo statunitense Abraham Maslow colloca sul secondo gradino della sua famosa piramide: il bisogno di appartenenza. Questo include i bisogni di amicizia, di affetto familiare e di intimità sessuale. L’appartenenza, il senso di essere parte di qualcosa è dunque un bisogno primario da soddisfare, una necessità cui nessun individuo può sottrarsi poiché insita nella sua stessa natura, ma che inesorabilmente lo costringe a fare i conti con l’Altro, l’altro da sé che per Sartre coincide obbligatoriamente con l’inferno. Un inferno costituito non tanto o non solo dalla schiavitù dei legami, quanto dal giudizio degli altri, ovvero dalla dimensione valutativa che qualunque relazione racchiude più o meno implicitamente. Dalla culla alla tomba, socialità e senso di solitudine duellano in noi, in una danza silenziosa con il tempo della vita e le sue istanze. Ma è davvero così distruttiva la presenza dell’altro? Aveva ragione Sartre ad individuare nel bisogno di socialità il presupposto imprescindibile dell’infelicità umana? E perché, allora, la solitudine si staglia sullo sfondo delle nostre vite come qualcosa da cui vorremmo fuggire?
Eppure il nostro sé e le sue rappresentazioni esistono solo in relazione all’Altro: io sono io, in quanto Tu agli occhi dell’altro- e lo stesso è questi per me- indissolubilmente legati dal filo invisibile che intesse le relazioni, invischiandole in trame soffocanti di bisogno e rifiuto, ribellione e rassegnazione, gioia e dolore e così via, sulla scia dell’irrinunciabile dualismo che da sempre attraversa la realtà e l’animo umano.
Ci sentiamo soli, in un oceano di relazioni. Eppure noi siamo relazione, ci sostanziamo di essa, la temiamo e spesso non riusciamo a gestirla: matrimoni che finiscono, amicizie parassitiche, figli dei quali sappiamo ben poco e che troppo spesso crescono soli. Non si tratta della questione della gestione dei conflitti, ma di qualcosa che li precede di molto e che costituisce il medium attraverso cui esse si esprimono: la comunicazione.
Comunicare è inevitabile per l’essere umano, che egli lo voglia oppure no; d’altronde il primo presupposto della comunicazione è l’impossibilità della non comunicazione: “non si può non comunicare”, poichè la mia sola esistenza è fonte di comunicazione ed il semplice fatto di esserci rappresenta una forma di comunicazione alla quale tutti dobbiamo sottostare. E così, il linguaggio, simbolo per eccellenza dell’atto comunicativo, ci tradisce nella sua forma non verbale: se anche per assurdo decidessimo di chiuderci nel mutismo più assoluto, il nostro corpo, i nostri gesti, le nostre espressioni parlerebbero per noi. E comunicherebbero all’altro molto della nostra essenza o, quantomeno, della nostra presenza, con o senza il nostro consenso. Che sia dunque una questione di comunicazione quella di cui si sta parlando? Forse è questo il vero ostacolo alle relazioni, forse il problema non risiede tanto nel senso di solitudine in quanto costitutivo dell’ essere umano, quanto piuttosto in una comunicazione malata che avvelena le relazioni, piegandole alla necessità della fuga invece che a quella dell’incontro: è più semplice ignorare che ascoltare, tacere che farsi ascoltare, lasciare andare che tenersi stretti. Forse se ci fermassimo tutti un momento ad ascoltarci e ad ascoltare, se smettessimo di sentire l’altro solo per il tempo necessario a dire la nostra e offrissimo invece il giusto ascolto al messaggio che ci viene comunicato, sospendendo il giudizio e mettendo in gioco l’empatia piuttosto che l’egocentrismo più sfrenato, se utilizzassimo quindi una comunicazione assertiva in luogo di una aggressiva/passiva, allora forse non ci sentiremmo più così soli. Anche senza like.


![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/Bibbia-2-218x150.jpg)

![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco (12, 28-34) [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/kiwihug-9uL9h8zaBc0-unsplash1-218x150.jpg)
![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/10/bible-1623181_1920-580x435-1-1-218x150.jpg)


![Visti da vicino – Festival del Cinema Europeo: ai microfoni di Paisemiu l’attore Fabio Traversa [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/Fabio-Traversa-2-218x150.jpg)

![Visti da vicino – Festival del Cinema Europeo: ai microfoni di Paisemiu il regista Edgar San Juan [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/Immagine-WhatsApp-2024-11-13-ore-14.58.32_86c679eb-218x150.jpg)