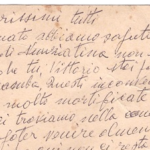L’aria di festa giunge anche qui. Come uno schiaffo che sorprende e crea un’eco che fa tanto male.
Oh, sì, mi manca tutto, finalmente lo ammetto. Anche se ho imparato a fare a meno di quello che non potrò avere. E mi rifugio nel sogno infinito e demenziale che mi costringo a vivere. Qui non ho appigli. Non un bicchiere di vino da mischiare al sangue delle mie ferite, non una mano che rammenti carezze ancestrali. Non ho che la mia mente, che è devastata dal silenzio di se stessa. La finestra è troppo in alto e non riflette che gocce di vita che non m’appartiene, il sole arriva sporco e la pioggia grigia. Un enorme capannone sfregiato dall’oblio.
Di tanto in tanto una voce mi chiama, mi dice che c’è qualcuno che vuole vedermi. Ed io vado incontro a occhi che forse sono stanchi di amarmi, come quei piedi vecchi e pieni di calli che non ne possono più di percorrere strade stracolme delle buche che io stesso ho creato. E quando incontro quella madre, non ho affatto voglia di abbracciarla, non mi dice nulla quel suo sguardo liquido e opaco. Abbiamo un problema di sincronismi. Quando mi servirebbe ritrovarmi nel suo grembo protettivo, lei non c’è; e quando c’è non la voglio io. Le mancanze arrivano senza avvisare, e quello è un momento critico, uno di quegli attimi in cui potrei fare del male a chiunque. O forse solo a me. Sempre in bilico tra una realtà impossibile da farmi bastare, e un sogno che sta somigliando ogni giorno di più alla follia. Infatti non so se ho ancora una madre, un passato, un’identità.
Tra un po’ dal muro marcio di questo tugurio trasuderanno rumori di festa e il cielo sarà distratto da luci artificiali e illusorie. Il televisore di un’immaginaria stanza accanto blatererà la solita musica e il vecchio ‘meno tre, due, uno …. Buon anno a tutti’.
Nella mia tana non ci sono elettrodomestici, caldo vischioso o freddo di lama, puzza di merda e calce disciolta come neve di pianura. Farinosa, opaca, di pessimo cielo.
L’idea della morte diventa compagna di respiri invisibili, via di fuga in un luogo dove non può evadere che il pensiero. E neanche quello. Perché la fantasia si prosciuga e si scontra con le briciole nere e appiccicaticce di un pavimento lercio.
È capodanno, lo sentono le mie orecchie sorde. L’attesa è logora, non ci sarà mai più una primavera. E improvvisamente ricordo quella notte trascorsa con te, noi due soli, sull’isola dei conigli. Illuminati dalla luna, faceva freddo, avevamo portato candele, calici di cristallo, spumante e una coperta di lana.
Salutammo il pescatore che un po’ perplesso ci lasciò sulle rive vergini dell’isola, e ci apprestammo a vivere quella notte avvolti in noi, in una lunga preghiera d’amore che ci avvicinò a Dio, all’Assoluto, al Cielo.
L’odore forte del mare e dei pini selvatici fu il profumo delle nostre carezze eterne, di quell’aleatorio quadro di felicità, i nostri piedi bagnati da quell’acqua gelida e viva, e le tue risate nell’infinito vuoto. Il cielo stellato di un dicembre improbabile, il nostro tetto. E le braccia pareti.
Il nostro capodanno, l’ultimo della tua vita. E della mia.
Ho voglia di ridere di me. Un uomo che arranca cercando di salvarsi dalle rovine di un sogno.
Perdi il lavoro, un pugno in pieno stomaco, e vivi al rallentatore, anche se pensi che non sia capitato a te. Poi pensi che ne troverai un altro, non importa quanti anni hai. Pensi che quei no che ricevi a raffica facciano parte di un incubo. Pensi che ce la farai, che hai ancora i tuoi risparmi, che potrai mangiare e vestirti, e forse fare un viaggio e arrivare fino a Parigi e salire fin sulla Torre Eiffel, e guardare il cielo da vicino. Ci andrai nelle notti d’estate sperando in stelle cadenti e sogni di carta. E poi piangi, perché il divano comodo ha finito di cullarti e la gente ti guarda come se vedesse scritta in volto la tua disperazione. La tua vergogna, e la stanchezza di ossa rassegnate. Ti guarda per un attimo e ti dimentica per sempre. I progetti diventano immagini lontane, e anche il passato cuce l’addio. Non riesco più a ricordare come sia avvenuta la fine. Imballare due cose e portarle nel deposito di una schiena ancora forte e dritta. E lasciare le chiavi di casa al proprietario come un’eredità triste, cominciare a camminare solo ma solo davvero. Punto. Chiuso. Fine. Nessuna pietà da accettare, nessuna lacrima da apprezzare, nessuna elemosina da spalmarsi addosso. Una vita da cassonetto, da vagone lurido, da fila ai bagni pubblici e alla mensa comune. Notti di angeli portatori gentili di coperte marroni, come quelle militari. Notti lunghe e disegnate con stalattiti di ghiaccio e fumo. Di poesia e maledizioni. Di rifiuti sul filo da funambolo, quando non vuoi farti trovare da chi ancora ti cerca. I capelli e la barba lunghi, e la vita oscurata da cortine di cemento. E il senso di colpa che ti serra la gola, e ti impedisce di respirare.
Io non credo più a niente, neanche a te, angelo custode. C’è una ragazza curiosa che mi ha regalato un cane. Dice che lui mi insegnerà ad amare. Nei suoi giri notturni simili ad apparizioni celesti, lei tenta di illuminare il mio sguardo. Suona il violino. Lo fa per me. Dice che ce la farò, che lei resterà mia amica anche se la caccerò. E’ tornata ogni notte, non ha saltato uno solo dei suoi appuntamenti muti. Per giorni o forse anni.
È capodanno. Credo. L’angelo è qui. Ha portato le candele, due bicchieri e una bottiglia di spumante. Come quella notte sull’isola dei conigli. Tutta la mia antica esistenza è volata via portando con sé dolori e amori. Fino nei dettagli. Non mi perdonerò mai. O forse sì, un giorno che da qui non si vede.
È capodanno. E quasi non riesco a credere a quella mano che prende un bicchiere e lo porta alla labbra dischiuse in un timido sorriso. Io. Un’emersione miracolosa di me, una sorta di ombra bianca che viene fuori da lacerazioni profonde. Ma c’è. Non ne ho meriti, e non so fin dove arriverà.
Intanto mi sveglio nell’alba chiara di un giorno che mi sembra nuovo. Sulle mie ginocchia ci sono, addormentati, un cane ed una ragazza che somiglia a un angelo. Più in là, due bicchieri ed un violino.
{loadposition addthis}


![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/Bibbia-2-218x150.jpg)

![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco (12, 28-34) [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/kiwihug-9uL9h8zaBc0-unsplash1-218x150.jpg)
![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/10/bible-1623181_1920-580x435-1-1-218x150.jpg)