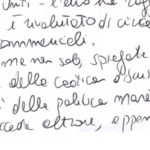Non mi uccidete. Non respiro. Mamma.
Non mi uccidete. Non respiro. Mamma.
Sono le ultime parole pronunciate da George Floyd prima di essere assassinato.
Il 17 luglio del 2014 Eric Garner ripete undici volte “Non riesco a respirare” prima di morire mentre un agente di polizia lo tiene immobilizzato.
La storia fa il giro e si ripete, laddove il razzismo non è solo un sostantivo in disuso. A dimostrazione che in sostanza poco è cambiato e che l’America della libertà è ancora troppo lontana dalle definizioni di umanità ed emancipazione reale dei diritti.
È questo 25 maggio 2020 che grida con tutta la sua forza, da più parti del mondo civile, contro un’ingiustizia senza scuse e senza alibi che non solo uccide, ma – cosa forse ancora più grave -, lo fa con assoluta mancanza del limite della vergogna e della stessa paura di ripercussioni giudiziarie.
George Floyd è morto. È morto schiacciato dal peso delle ginocchia di un poliziotto, ma soprattutto dal peso del razzismo per cui anche il sindaco di Minneapolis – luogo dove si è consumata la tragedia – ha dichiarato «Quell’uomo non avrebbe dovuto morire. Essere un nero in America non dovrebbe essere una sentenza di morte». Invece un uomo è morto, e con i verbi coniugati al condizionale non si fa nessun passo avanti.
 Come si muore soffocati?
Come si muore soffocati?
Si muore dopo sei, otto minuti, un tempo infinito se trascorso nella piena consapevolezza. Si avverte quella fame d’aria per cui si tenta con ogni forza di accaparrarsi un minimo di ossigeno. Il sangue si riempie di anidride carbonica fino a ridurre le pupille a due vetri concavi che fuoriescono dalle orbite e implorano pietà. Gli sfinteri perdono il controllo: la bava fuoriesce dalla bocca, così l’urina e le feci, mentre si lotta ancora e ancora per sperare di trovare quell’aria che potrebbe mettere fine all’agonia. Ma il cuore e il cervello cominciano ad arrendersi, a rassegnarsi al fatto che non c’è niente da fare.
Così si muore.
In modo atroce.
Per un abuso. Per sfortuna. Nel mondo dei diritti negati. Nel mondo dove vincono gli oppressori. Si muore mentre ci si rifugia nella parola mamma, colei che per definizione dà la vita, in una sorta di staffetta che lega i due momenti topici di ogni esistenza: la nascita e la morte.
Mamma. Mentre un uomo che doveva tutelare anche lui, lo uccideva col sorriso sulle labbra. La posa da duro, la mano in tasca, un sorriso per la stampa.
Mamma, mamma. E quello schiacciava, si accomodava con tutto il suo orribile, disumano peso sulla vita che finiva. Mamma mamma, e un ultimo pensiero. Un addio.
Potessi scegliere quale madre essere, sceglierei di essere la madre di George. Di quell’altro figlio mi vergognerei fino alla morte.


![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/Bibbia-2-218x150.jpg)

![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco (12, 28-34) [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/kiwihug-9uL9h8zaBc0-unsplash1-218x150.jpg)
![Riflessi nell’anima – Lectio Divina sul Vangelo di Marco [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/10/bible-1623181_1920-580x435-1-1-218x150.jpg)

![Visti da vicino – Festival del Cinema Europeo: ai microfoni di Paisemiu l’attore Fabio Traversa [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/Fabio-Traversa-2-218x150.jpg)

![Visti da vicino – Festival del Cinema Europeo: ai microfoni di Paisemiu il regista Edgar San Juan [VIDEO]](https://www.paisemiu.com/wp-content/uploads/2024/11/Immagine-WhatsApp-2024-11-13-ore-14.58.32_86c679eb-218x150.jpg)